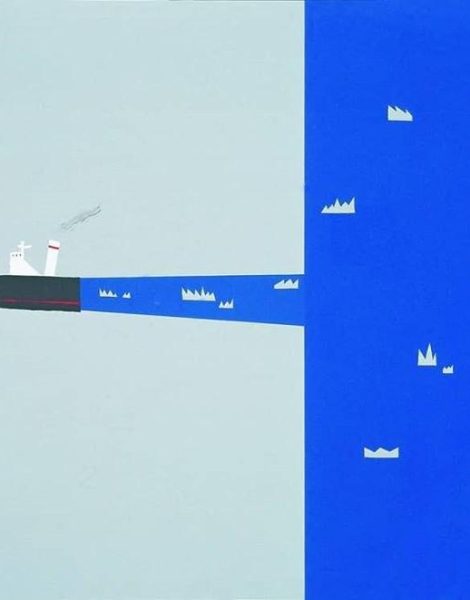Riceviamo e pubblichiamo il contributo che segue di Nicola Borghesi, regista e attore, fondatore della compagnia bolognese Kepler-452. Lo scritto allinea diversi punti per pensare il teatro del presente e del futuro, senza dimenticare il recentissimo passato e certe questioni endemiche del teatro e della società. Crediamo infatti che continui a essere urgente discutere e anche litigare sui motivi che ci hanno portato a essere così pochi, se pensiamo al numero di persone interessate al teatro oggi in Italia (ne parlavamo in due diversi interventi durante l’isolamento, scritti da Lorenzo Donati e a firma collettiva su Doppiozero). Crediamo sia vitale porci domande sulla maniera attraverso cui il teatro oggi in Italia è organizzato e finanziato, guardando da vicino la questione del teatro pubblico e di quello privato, ambiti spesso intrecciati; crediamo infine che ogni discorso sul presente e sul futuro del teatro debba essere accompagnato da riflessioni e proposte di stampo educativo e pedagogico, una questione enormemente complessa che non può essere risolta con il fiato spesso corto dell’audience development. Di tutto questo e molto altro ci invita a discutere Nicola Borghesi, aprendo un dibattito che, dopo la convocazione di un‘assemblea del teatro, vorremmo cercare di tenere aperto anche con futuri contributi nostri e di altre voci provenienti dal teatro. (Altre Velocità)
Qualche giorno fa, all’alba della cosiddetta “fase 2”, abbiamo diffuso un comunicato a firma Kepler-452 (il primo comunicato della pur breve storia della nostra compagnia). Da giorni penso che molte delle cose che abbiamo scritto meritino di essere approfondite. Ci provo.
Sul problema sindacale
Le lotte per il salario e il miglioramento delle condizioni di lavoro sono, all’interno del capitalismo, sempre e necessariamente progressive e quella del comparto teatrale non può (non dovrebbe) fare eccezione. Tuttavia, nel caso specifico delle lotte teatrali, ci sono alcuni punti da prendere in considerazione che non valgono necessariamente per gli altri ambiti, proprio in virtù di quell’ineffabile magia propria del lavoro teatrale, che resiste sempre e fermamente a ogni tentativo di istituzionalizzazione, quand’anche essa desiderasse essere progressiva e benefica per gli artisti stessi.
Oltre a questa prima premessa ne aggiungo una seconda: quanto scriverò di seguito vale per il teatro di cui tendenzialmente mi occupo io, insieme alla mia compagnia, ossia il teatro finanziato dallo Stato, non già per quello cosiddetto commerciale, quello insomma che si sostiene, virtuosamente, coi biglietti e con la circuitazione e che, tendenzialmente, fa uso di “nomi di richiamo” (cosa che è capitata anche a noi, pur restando all’interno della prima delle categorie citate) o altri ingegnosi sistemi di richiamo del grande pubblico (titoli famosi, giornalisti famosi ecc.).
Fatte queste dovute premesse, passo a una serie di punti che rischiano l’impopolarità e comincio da un dato certamente spiacevole: molte delle richieste provenienti dal settore del teatro rischiano in questo momento di essere del tutto incomprensibili agli altri lavoratori, quando non addirittura insensate in se stesse. Aggiungo qui un’ultima premessa: non mi riferisco a nessun movimento specifico tra quelli sorti in questo periodo, ma a una certa “voce di popolo” che ho percepito frequentando gruppi, leggendo post, ascoltando interventi in streaming.
Parto dalla più evidente, che ha molto tenuto banco negli ultimi tempi, perché la ritengo esemplificativa: la battaglia per l’allargamento della platea di coloro che possono beneficiare del bonus covid per i lavoratori dello spettacolo. Le giornate necessarie per riceverlo fissate dall’INPS sono 30, in un anno. Non sono tante, sono molto poche. Chi fa trenta giornate lavorative in un anno non si mantiene per un anno, a meno che queste non siano pagate cifre esorbitanti. Certo si può dire che molti artisti, tra cui il sottoscritto, si mantengano nei modi più disparati, pur restando all’interno dell’ambito teatrale (laboratori, corsi, attività varie). Tutto questo lavoro, però, non passa attraverso giornate ex-enpals versate, ma in un regime di continua precarietà (lavoro nero, ritenute d’acconto ecc.). In questo caso l’obiezione vien da sé: ma se non abbiamo versato, non abbiamo contribuito, abbiamo agito in un sistema parallelo, rabberciato e poco chiaro, come possiamo poi pretendere di vedere riconosciute le nostre prerogative in un momento di crisi? Non lo dico a detrimento dei lavoratori che non raggiungono le famose 30 giornate, lo dico in un’ottica di comprensione del sistema complessivo. Ci sono poi molti giusti appunti che vengono mossi a questo sistema: può essere stato un anno sfortunato e si deve guardare allo storico di ogni lavoratore; ci si può muovere a cavallo di diversi ambiti artistici avendo versato diversi tipi di contributi che non vengono cumulati; si può essere percettori di altri (spesso risibili) contributi che rendono impossibile la ricezione del bonus. Le casistiche sono molte e complesse.
Ciò non toglie che in moltissimi casi queste battaglie, e qui certamente dico la cosa più impopolare e spiacevole in assoluto, non hanno in realtà un profilo sindacale, ma identitario. Non si muovono sull’ascissa di Marx, ma sull’ordinata di Freud. Non sono battaglie che chiedono di poter godere dei giusti diritti dei lavoratori dello spettacolo, ma battaglie che rivendicano, disperatamente, di essere dei lavoratori dello spettacolo, di appartenere a un mondo di cui, in fondo, non si sentono parte. Siamo di fronte, dunque, ad un gruppo numericamente rilevante di persone che aspirano, con più o meno continuità a essere lavoratori dello spettacolo, senza riuscirci. O riuscendoci in modo intermittente. O che lo fanno ormai da anni stabilmente e campandoci ma sono sempre a rischio di venire retrocessi, in tempo brevissimo, nel girone di quelli che non ce la fanno. Siamo di fronte dunque a un cosmo di sommersi e salvati. Molti i sommersi, pochi i salvati, moltissimi (tra cui io stesso che scrivo) in un eterno limbo tra i due, continuamente affannati a tenersi a galla. Temo che, senza cominciare da questo punto, autenticamente doloroso, non si vada da nessuna parte.
Ci sarebbero poi alcune altre battaglie sindacali da prendere in considerazione, altrettanto rivelatrici di moti profondi dell’anima. Magari ne parleremo dopo.
Il senso politico del bisogno di appartenenza
Se, come abbiamo detto, la lotta per l’estensione del diritto ai 600 euro anche a chi ha meno di 30 giornate lavorative in un anno è una lotta identitaria e non economica, vale forse la pena di prendere in esame cosa questa istanza ci suggerisce, in un senso più ampio. Mi pare che la categoria a cui appartengo (o almeno molti tra di essi), con questa rivendicazione insensata, abbia abbandonato il campo della realtà, per rifugiarsi in una narrazione egotica e autoreferenziale. Il bisogno di essere cittadini vivi, all’interno di un tessuto sociale che ne sente il bisogno, è stata soppiantata dal bisogno di riconoscimento. Non si guarda dunque al sistema che ci soffoca come a una controparte contro la quale lottare, da sfidare, cambiare (se non come a un padre da uccidere), al contrario: si chiede a questo sistema, a questo padre, l’approvazione, il riconoscimento, come ragazzini discoli che, al netto del loro essere scapestrati, vorrebbero far parte del consesso dei grandi. Ci si pone dunque nella postura dei questuanti, non di quattrini, ma di approvazione.
Trovo che questa tendenza pericolosissima, esiziale sia la giusta conseguenza del teatro che spesso ci troviamo a guardare in sala: rassicurante, problematico più nella forma che nel contenuto, spesso ornamentale. Con ornamentale intendo dire aderente a quella retorica che spesso si sente ripetere in televisione: la bellezza ci salverà. Come se il teatro, l’arte, dovessero essere belli nel senso corrente con cui si impiega questo termine. Come se dovessimo compiacere la mamma, anziché, come sarebbe giusto, sfidarla, ferirla, farla migliorare, con amore. Con questo pensiamo di dare al pubblico, attraverso il nostro lavoro, ciò di cui ha bisogno, mentre partecipiamo a un’operazione di maquillage nella quale altri mezzi (video, canzoni, film) hanno strumenti assai più affilati dei nostri, meritandoci così il ruolo di cenerentole di cui tanto ci lamentiamo.
Forse per immaginare un teatro nuovo e più necessario, questo bisogno di riconoscimento, di sicurezza, andrebbe analizzato a fondo.

Ancora sui 600 euro
Mentre scrivo accadono due fatti, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro: l’estensione del bonus covid anche a chi ha 7 (sette!) giornate lavorative nell’ultimo anno e, poco dopo, l’annuncio della riapertura dei teatri dal 15 giugno. Il capolavoro è servito. Il comparto, nella sua immagine esterna, ha comunicato due istanze: sussidi per tutti (anche per chi, concretamente, non si occupa di teatro nella vita) e riapertura immediata (vedi la sciocca polemica nella quale si accomuna la riapertura delle chiese a quella dei teatri). Accontentati, gli artisti si trovano giustamente cornuti e mazziati: sale aperte a condizioni molto difficili, nelle quali pochi potranno lavorare, e privati da giugno in poi del famoso bonus che diventa, come da richiesta, una mancetta per tutti ma solo per due mesi. Poi tutti di nuovo sul mercato del lavoro, di fatto quasi inesistente. Di rado una lotta è stata più controproducente. Bravi tutti.
Sulla mia bacheca Facebook ha fatto trionfalmente ingresso la realtà sotto forma di un commento di un amico tassista, lo riporto testualmente: «appena un vostro collega mi accusa di fare del nero si becca degli schiaffi». I lavoratori di altri settori attenti alle rivendicazioni della nostra categoria (per fortuna pochi) che immagine dovrebbero avere di noi? Avevamo due possibilità: piagnoni garantiti o avanguardie nella rivendicazione del reddito universale di quarantena. Una larga parte di noi ha scelto di proiettare di sé la prima immagine, con l’aggravante che non siamo nemmeno garantiti, in realtà.
Il collo di bottiglia
Ma, tornando a noi, per quale motivo c’è un così profondo oceano di sommersi che vorrebbero far parte dei lavoratori dello spettacolo? La risposta è semplice e ce la fornisce l’economia più basilare: l’offerta di lavoratori dello spettacolo (di artisti in particolare) è enormemente superiore alla domanda. Questo è un fatto. Qualche tempo fa mi trovai a discutere con il mio responsabile di produzione, persona a cui sono affezionatissimo, su un semplice problema: perché io, che sono il regista dello spettacolo, ci recito dentro e l’ho scritto insieme agli altri, perché io guadagno, a giornata, meno di tutti coloro che lavorano intorno allo spettacolo (tecnici, personale amministrativo, ufficio stampa, ufficio comunicazione)? La risposta è stata lapidaria e giustissima: perché per tutte le altre figure c’è un mercato molto più ristretto. Un fonico o un datore luci bravo come quello che segue il vostro spettacolo è difficile da trovare, mentre di registi, attori, drammaturghi, là fuori ce n’è una fila, che vorrebbero essere al tuo posto. Questa affermazione, grandiosa nella suo essere lapidaria, contiene un’insidia: il lavoro, ad esempio, del fonico, è facilmente misurabile, nella sua qualità, quello di un artista è discutibile all’infinito. Non ci si è, insomma, per certi aspetti giustamente, accordati su quali siano le qualità che rendono un regista preferibile a un altro.
La popolarità (e dunque la capacità di richiamare pubblico) non è un buon metro, sarebbe facilmente confondibile con quello del teatro commerciale, o “di cassetta”, come si diceva una volta. In sintesi: se si ripagasse da solo attraverso i biglietti, che bisogno ci sarebbe di un intervento finanziario dello Stato? Anche l’apprezzamento da parte dell’ambiente critico/accademico è un criterio che presenta lacune molto evidenti: per anni, in molti casi, sono stati promossi e prodotti artisti e lavori che, pur concettualmente ed esteticamente grandiosi, mozzafiato addirittura, non hanno sviluppato la capacità teatrale di rivolgersi a un pubblico non dico ampio, ma almeno rilevante. Di creare, attorno al proprio percorso, una prossimità che non riguardasse solo gli addetti ai lavori. Di utilizzare, in ultima istanza, un linguaggio che potesse riguardare una fetta della popolazione magari specifica, ma esistente.
Il vero criterio, ossia quanto si è importanti o necessari per un pubblico, magari non quantitativamente enorme, ma almeno esistente e specifico, è impossibile da dispiegare, per un semplice motivo: il pubblico scarseggia. E quel poco che c’è viene conteso tra le diverse iniziative esistenti, che vivono continuamente nel terrore di sovrapporsi e nella competizione per accaparrarsi quei pochi, laddove invece la sfida sarebbe di ampliare il gruppo di coloro che dovrebbero competere, loro, per vedere gli spettacoli.
Audience development e altre astrazioni
Il pubblico interessato al teatro è poco, pochissimo e questo è sempre il grande assente della discussione. Quando poi questo punto compare, lo fa spesso nelle sembianze di accorati discorsi sull’audience development, che spesso vengono condotti senza tener conto dell’oggetto intorno al quale questa audience dovrebbe essere developed. Come se, per allargare la platea, l’oggetto centrale non fosse ciò che accade sul palcoscenico. Il teatro non è in crisi perché la proposta è efficace ma nessuno ne è a conoscenza. È in crisi perché nella maggior parte dei casi chi viene a teatro vede qualcosa che non lo porterà a tornare. Quali siano i motivi per cui questo accade è complesso e meriterebbe un ulteriore approfondimento, che lascio a chi si occupa di teatro da un punto di vista critico. Tuttavia chi vede una grande quantità di spettacoli sa certamente quante visioni faticose e insoddisfacenti bisogna affrontare, prima di trovarsi di fronte a qualcosa che ci faccia dire: «ecco!». Quanto generoso è lo slancio che si chiede al pubblico che sa che ciò che vedrà in scena, la maggior parte delle volte, lo deluderà? Si può chiedere tutta questa pazienza a un cristiano? D’altra parte ci sentiamo, io per primo, di garantire sempre un risultato all’altezza delle aspettative? Semplicemente: no.
Tornando all’inizio della riflessione: tutti questi artisti che rivendicano la propria appartenenza al mondo dello spettacolo, la rivendicano in riferimento a questo mondo dello spettacolo? Nella maggior parte dei casi temo che la risposta sia: sì. Si desidera, insomma, entrare a far parte di un mondo che, anche se ne fai parte, non incide, spesso, in alcun modo sulla realtà. Lo si desidera contro ogni senso, perché la vocazione è così: hai voglia di fare qualcosa, hai quell’immagine lì, vaga e meravigliosa e dolorosissima, con le luci e le tavole di legno e le poltrone e il pubblico, ma nessuna chiarezza sul cosa o sul come. Né soprattutto, sul contesto all’interno del quale questo cosa e questo come dovrebbero accadere: lo stadio di avanzamento del capitalismo all’interno del quale ci troviamo e il ruolo che vorremmo avere all’interno di esso. Questa consapevolezza dovrebbe essere importante quanto il talento. Anzi, forse, questa consapevolezza è il talento.
Noi siamo qui
Ma perché non esiste un pubblico disposto a fallire numerose visioni per portarsene a casa una, o due, veramente memorabili e capaci di cambiarti la vita?
Quello artistico è un percorso complesso, che non sempre dà i frutti desiderati, e a volte anche quelli desiderati non sono fatti fino in fondo per essere condivisi. Perché contempla e tutela l’errore e la stortura e la fragilità e il fallimento, tutti elementi fortemente censurati nel mondo circostante. Insomma, per fare uno spettacolo davvero memorabile bisogna correre il rischio di fallire e bisogna aver fallito molte e molte volte in precedenza, penso saremo tutti d’accordo. Dunque il teatro sovvenzionato deve, per l’appunto, sovvenzionare questi fallimenti, prendersene cura, dare ad essi spazio e legittimità. Esistono per questo, in fondo, le sovvenzioni.
Qua ci si presentano due problemi.
Il primo: chi ci garantisce che il percorso della compagnia non sia semplicemente un susseguirsi di fallimenti, senza un’oncia di talento o qualcosa da dire (cosa che, per esperienza comune di tutti, capita spessissimo)? Siamo daccapo: i direttori artistici? I critici? Forse, in parte, ma comunque no, non è quello il punto. La risposta, in un mondo migliore, dovrebbe essere: il pubblico. Quale pubblico? Quel pubblico che è disposto a guardare tentativi e fallimenti, a patto che intraveda in essi una promessa di meraviglia.
Il secondo problema: quel pubblico non esiste. E perché non esiste? Perché nella straordinaria pressione esercitata dal tutto orribile universale che ci circonda, questi spettatori, semplicemente non possono darsi. Come possiamo immaginare che un individuo, costantemente molestato dalla competizione, dalla necessità del successo, dall’obbligo di considerare qualsiasi cosa (dalla casa all’amore) sostituibile alla luce del principio di scambio, possa perdere tempo a contemplare dei fallimenti o dei semifallimenti o dei capolavori saltuari? Come direbbe Adorno: non si può erigere il vero nel falso universale. Semplicemente, nel capitalismo, un sistema teatrale molto migliore di questo non si può dare. Che fare, dunque? Pretendere un sistema nel quale il nostro teatro possa avere senso, anziché pretendere che il nostro teatro possa esistere in un sistema nel quale semplicemente non può esistere.
La catena di scarico dell’odio teatrale
C’è molto odio, in giro, in questo momento, al netto degli hashtag #andràtuttobene e #celafaremo. Il punto dell’odio, come sappiamo, è che non va rimosso, ignorato, perché è un odio giusto. Va semplicemente indirizzato. Provo quindi a ipotizzare una catena di scarico dell’odio valida per i lavoratori del comparto teatrale.
La catena di scarico dell’odio dovrebbe essere così concepita:
- Il problema sono i Teatri Nazionali o i TRIC o gli enti produttivi e di ospitalità in genere? No, loro fanno quello che possono in un contesto di scarsità di mezzi. Potrebbero fare meglio e con più coraggio? Sì. Talvolta abusano della propria posizione di potere? Sì. Tuttavia nel contesto di tagli e regole provenienti dal Ministero, non si può certo considerarli integralmente come delle controparti. Anzi, in molti casi sono vittime come noi dello stesso sistema sbagliato e carente. Potenzialmente, se fossero animati da persone di buona volontà (come in alcuni casi già è) più compagni di lotta, che controparte.
- Il problema è dunque il Ministero? Certamente il Ministero, le sue politiche, le regole che impone, sono parte del problema. Tuttavia, immaginiamo davvero che i ministri che si sono susseguiti abbiano interpretato volentieri la parte degli affamatori sordi alle richieste dei lavoratori del settore? Credo di no. Credo semplicemente che abbiano eseguito sentenze scritte da altri. Che abbiano tagliato perché nel sistema dato (il tardo capitalismo) la cultura, nel medio termine, non si può che tagliare. Che abbiano managerializzato perché in un contesto in cui tutto è profittevole e manageriale, non si capisce perché la cultura debba fare eccezione.
- Il problema è dunque la classe politica, il personale politico? In fondo, nemmeno. Certo, fanno orrore. Sono per lo più lombrosiani, stupidi, rotti ad ogni compromesso, mostruosi. Ma, a loro volta, fanno ciò che devono fare nel sistema dato, nel momento specifico che questo sistema attraversa. Eseguono, come sappiamo, sentenze scritte altrove. Forse nemmeno altrove, in un altro tempo. Inseguono l’esaurimento delle risorse, l’impoverimento dell’occidente, la catastrofe climatica (pur senza vederla), un mondo multipolare che si affaccia e, soprattutto, la crisi strutturale di accumulazione del capitale globale. Sono degli incompetenti alla guida di una barca alla deriva. Non sono malvagi, sono semplicemente degli inetti impotenti. Le due cose, in realtà, non si escludono, ma questo non toglie che essi non sono in definitiva il terminale ultimo del nostro odio.
- Quale è, dunque, il problema? Il problema, sorpresa delle sorprese, è il capitalismo e gli inesistenti spazi di manovra che lascia alla classe politica. Più specificamene, nel nostro caso, è quel famoso “pilota automatico” di cui parlò, schiettamente, il primo ministro in pectore Mario Draghi. Senza abbattere quel pilota automatico, infine, non si può dare il teatro che vogliamo.
In conclusione di questa catena di scarico dell’odio possiamo dire che, se non riusciamo a fare il nostro lavoro di artisti, sia per le condizioni materiali che per le condizioni spirituali nelle quali siamo posti, la causa è da ricercarsi, nel momento storico determinato in cui ci troviamo, nelle forze d’inerzia che lo governano. La nostra controparte è il pilota automatico, il quale a sua volta è l’espressione del capitalismo in questa fase. La nostra controparte, in sintesi, è il capitalismo.

La fase 1
Mentre scrivo, agli albori della fase 2, percepisco, da parte di molti colleghi, una tremenda voglia di tornare alla normalità. Le strade, da silenziose e ferme, rimbombano di nuovo di operosità e motori.
Nella fase 1 tutto era fermo e questo ci faceva sentire autorizzati a star fermi anche noi, godendo (inutile negarlo) dell’allineamento della società tutta alla nostra virtuosa inutilità. Abbiamo avuto tempo di fermarci, di ascoltare, di leggere, di far niente, nel migliore dei casi di renderci conto della sofferenza che la nostra vita ci procura e piangerne un po’. Di confrontarci con la domanda che si pone il protagonista di Delitto e castigo: «Ma io, sono come un insetto o come Napoleone?». Insomma la fase 1 ci ha dato la possibilità, nel contempo, di riposarci e di confrontarci con la nostra miseria. Di accorgerci quanto poco siamo necessari e richiesti e, forse proprio in virtù di questo, di riposarci e volerci anche un po’ bene. Nel mio caso anche di cucinare, leggere, scrivere, dormire (sognare forse), stare con chi amo. Tutte cose che spesso trascuro di fare per fare il teatro, come se il teatro potesse essere fatto da uno che non fa bene tutte le cose precedentemente elencate. Nella fase 1 è stata sospesa d’imperio quella che gli anglofoni chiamano FOMO – Fear of missing out, la paura di perdersi qualcosa. Non c’era niente da perdersi fuori, nessuna festa, e l’epicentro del mondo eri finalmente tu, la tua quiete, la tua solitudine, la tua miseria, i tuoi entusiasmi. Insomma le condizioni ottimali per porre i presupposti di un qualunque atto creativo. Dico presupposti perché nell’atto teatrale si prevede, in un secondo momento, di metterle in comune questa quiete, queste solitudini, queste miserie, questi entusiasmi, e trasformarli in materia viva, in continua trasformazione e dialogo con gli spettatori.
Nella fase 1, per qualche giorno, il sistema è andato quasi in blocco, vittima di un guasto che ne ha richiesto il pur temporaneo e parziale arresto, o almeno così ci è sembrato. Per qualche istante abbiamo addirittura creduto che da questo arresto, da questa pagina bianca, si potesse scrivere qualcosa di nuovo, di importante. Naturalmente era una percezione sbagliata, materialisticamente, ma quell’eco ci ha risvegliato come l’idea che un mondo, un’organizzazione della realtà, una società diversa fossero possibili. Altro presupposto fondamentale dell’atto creativo: raccontare la realtà perché si coltiva la speranza che essa possa essere fatta nuova, diversa.
Infine, e forse soprattutto, per qualche giorno abbiamo smesso di rimuovere completamente la prospettiva della morte, grande assente di tutte le nostre conversazioni. Per qualche giorno ci ha invece camminato accanto, snocciolata lugubre nel bollettino delle 18, come la tetra tombola di Maša alla fine del Gabbiano. Ed ecco un ulteriore presupposto della creazione: la vicinanza alle cose innominabili, grandi, rimosse.
Quante cose necessarie, per noialtri, nella fase 1.
Eppure in questa fase 1 noi artisti si smaniava di riprendere quella normalità atroce che abbiamo descritto fin qua. Nel terrore di essere dimenticati (che poi: ma chi ci ha mai ricordato?) molti hanno reclamato la riapertura a qualunque costo, lanciandosi in ridicoli parallelismi con la messa cattolica, con gli effetti concreti che abbiamo già descritto. In alcuni, più gravi, casi questa fretta di ripartire è stata addirittura venata da alcune tracce di complottismo, come ben evidenziato dal successo, presso la nostra categoria, degli infelici articoli che Agamben ci ha propinato nel corso di questa pandemia, così sinistramente e significativamente simili agli argomenti di Forza Nuova.
Ed eccoci così accodati alle più retrive posizioni di Confindustria, smaniosi di fare, fare, fare, di riaprire a costo della vita (meglio se degli altri), di esistere, di non scomparire, di essere guardati a prescindere, senza nemmeno l’ambizione di produrre qualcosa per cui valga la pena di essere guardati. Chiedendo di riaprire in preda alla necessità (ma quanti di noi erano certi di guadagnare tutti i mesi 600 euro?) e all’horror vacui, senza nemmeno esserci posti, nella maggior parte dei casi, il problema di che cosa avesse senso fare, come artisti, in questa fase 2. Desiderando ardentemente di dimenticarci della fase 1, un momento invece centrale delle nostre vite, di cui dovremmo, per molti motivi, cercare di serbare memoria. Coinvolti a nostra volta in quest’orgia di consumare ed essere consumati, un comparto produttivo qualsiasi tra gli altri, come la Federalberghi o la Confesercenti.
Anche molti di noi, insomma, hanno scelto la strada della rimozione. Senza contare che è una rimozione potenzialmente pericolosa perché, come sappiamo, il virus non è scomparso e non aspetta altro che i nostri comportamenti produttivi e irresponsabili per tornare a mietere vittime.
La fase 2
Giuseppe Conte, nella sua ultima conferenza stampa, lo ha detto chiaramente: non sarebbe il momento di riaprire, ma non possiamo permetterci di restare chiusi, non ci sono le risorse economiche per farlo. Ed è vero, almeno nel sistema dato, che però, appunto, a quanto pare non pensiamo sia in alcun modo modificabile.
Si apre così una fase orribile, non solo in contrasto alla grazia e all’epica proprie della fase 1, ma anche per alcune caratteristiche intrinseche: una realtà il cui unico fine dichiarato è il consumo. Ci scarcerano con il patto che noi andremo a consumare il più possibile nel minor tempo possibile per salvare quante più attività produttive possibile: per salvare questa economia, questo sistema produttivo che ci avvelena, nel corpo e nello spirito. Che, come abbiamo visto, necrotizza sempre più il nostro organo del teatro.
Dunque, che fare?
Continuare a tutti i costi facendo quello che si faceva prima, solo in condizioni mutate? Penso che questa soluzione sia da fuggire come la peste e non starei nemmeno a discuterne. Si dovrebbe cercare di evitarlo per quanto possibile, anche se in alcuni casi toccherà farlo, tenendo presente che il teatro ha la salvifica virtù di non poter prescindere dal contesto in cui accade. Importante sarà, in ogni caso, cercare di non prendere parte alla propaganda della riapertura, che ci vuole consumatori di tutto, anche di eventi, ordinati ed entusiasti, anche in condizioni nelle quali godere di un momento di socialità in sicurezza è sostanzialmente impossibile. Consumatori entusiasti senza neppure più il piacere misero del consumo. Dunque tutta la serie di foto di gente felice che fa allegramente ciò che faceva prima con guanti e mascherina a un metro di distanza è da considerarsi propaganda alla quale, se possibile, non dovremmo partecipare, così come a tutta la narrazione che si oppone in modo muscolare al virus, rispetto al quale noi saremmo “più forti”, qualunque cosa questo voglia dire. Questo tipo di retorica sarebbe opportuno lasciarla alla pubblicità.
Provo a pensare alcuni punti che potremmo tentare di portare con noi, nella speranza di non dimenticarci di tutto a nostra volta.
- Sarebbe importante tentare di costruire narrazioni che non solo non abbiano fretta di rimuovere quanto è successo, ma che tentino anche di conservare memoria di ciò che è stata la fase 1 e quali contraddizioni questa ha mostrato, cercando di evocare ancora e ancora i fondamentali conflitti di fronte ai quali ci siamo tutti trovati.
- È un errore la levata di scudi contro la richiesta di distanziamento fisico tra gli attori, in primo luogo perché, così facendo, stiamo prendendo apertamente posizione contro la tutela della salute dei lavoratori (e ancora una volta ci si presenta la domanda: ma noi, come categoria, nel campo del conflitto nel mondo del lavoro, dove vogliamo posizionarci?). Inoltre questa protesta, piuttosto puerile, rileva un altro dato sostanziale: dopo tutto questo, ci pare eccessiva anche solo la richiesta di mettere mano alla prossemica dei nostri spettacoli? Se siamo così poco disposti a cambiare, difficile intravvedere una possibilità di miglioramento delle condizioni di lavoro e produzione della categoria.
- Come artisti, dal punto di vista formale, il nostro compito dovrebbe essere quello di scovare, nella realtà, contraddizioni e sguardi nuovi. Come teatranti, sappiamo che il primo dovere di fedeltà lo dobbiamo alla circostanza data che si crea all’interno della sala teatrale, prescindere da questa ci relega al ruolo di macchiette. Insomma, quando e se dovremo adattare uno spettacolo a causa del distanziamento o di altre misure, penso dovremmo fare sì che questa distanza diventi drammaturgia e memoria della nostra condizione di sopravvissuti, al capitalismo prima ancora che al virus.
- L’abbandono del campo, a mio avviso, non è un’opzione, per un semplice motivo: dove non c’è qualcosa, c’è qualcosa d’altro, gli spazi che vengono abbandonati, verranno occupati da qualcun altro. Mi pare che di spazio, in questi anni, ne abbiamo già ceduto abbastanza. Il che mi porta a una riflessione: perché, in Italia, quando pensiamo a scelte radicali, immaginiamo sempre scelte di ascesi e solitudine? Come si è formato nel nostro immaginario l’equazione: radicalità uguale fuga in un luogo isolato, lontano da tutti, immersi nella contemplazione della purezza dell’arte? Ne I giganti della montagna di Pirandello alla contessa Ilse viene offerta la possibilità dell’ascesi, dell’abbandono della crudeltà del mondo per potersi isolare a Villa Scalogna, circondata da fantasmi e fantocci animati. Ilse è tentata, i suoi attori ancora di più. Ma sceglie di continuare a recitare, anche di fronte ai brutali Giganti della montagna, anche a costo della vita. Perché lì stanno i teatranti, in mezzo al mondo orribile e duro e spietato, che alla fine se li mangia.
- Bisognerà assumersi, come attori, registi, drammaturghi, la responsabilità di allargare il pubblico. Strappare questa missione agli organizzatori, ai comunicatori, agli uffici stampa, agli audience developer, e restituirla a chi di competenza: gli artisti. Far scaturire dalla presenza degli artisti nella società (e dalla qualità di questa presenza!) ciò che serve a portare gli spettatori in sala, come pifferai magici. Brecht era ossessionato dal fatto che i nazisti, avendolo strappato al palcoscenico, lo avessero reso un artista borghese. Dovremmo vivere la stessa ossessione, solo che a noi non hanno tolto il palcoscenico, ma gli spettatori.
- Toccherà arrangiarsi, ancora peggio, ancora di più. Saranno da prediligere valige leggere, strutture agili, palchi improvvisati, scene essenziali, incursioni in luoghi inusuali. Ci sarà da raggranellare i soldi che servono alla sopravvivenza in modi creativi e inaspettati. Questo non solo per la difficile situazione economica in cui il paese si troverà, ma perché abbiamo capito che il consumo di cose non salverà nessuno, meno che mai gli spettacoli. Bisognerà essere un po’ pirati, avendo sempre cura e attenzione di non garantire a nessuno una eccessiva estrazione di plusvalore dal nostro lavoro. Un equilibrio sicuramente difficile.
- Forse dovremmo occuparci, ciascuno a suo modo, di incunearci nei conflitti che si stanno aprendo, visitando fabbriche che chiudono, parlando con persone che (come molti di noi) stanno perdendo il lavoro, partecipando a lotte, dialogando con persone che non la pensano come noi, litigandoci anche, magari. Forse dovremmo uscire in strada, ora che possiamo farlo, per andare a scovare la vita, il conflitto, l’odio, l’orrore, la rabbia, la paura, la violenza. Attraversare la miseria del capitalismo nella sua fase di contrazione, sostarci dentro e lasciarcene influenzare. Poi raccontarlo. Ciascuno a suo modo, con i suoi strumenti, le sue capacità. Trascinandoci dietro le persone che abbiamo incontrato nel percorso, raccontandolo anche a loro, anche a chi pensiamo non possa capire, rimarremo stupiti. Radicalizzarci nel nostro sguardo sul mondo e nella frequentazione della realtà, non dedicandoci all’ascesi. Radicalizzarci cercando di individuare ogni volta, di volta in volta, i nemici veri, non quelli fittizi.
Finale
Sono trascorsi molti giorni da quando ho cominciato a scrivere tutto questo. O forse sono in fondo pochi ma sembrano un’epoca. L’invecchiamento di ciò che ho scritto mi è tristemente evidente, così come è sorprendente la velocità con cui è avvenuto. Questo mi causa una strana sensazione di malinconia, anche se non lo reputo del tutto un difetto. Mentre scrivo, tra pochi giorni, ricomincerà il teatro, anche il nostro, seguendo i punti che ho esposto prima. Alcune istanze sindacali di cui ho parlato in principio si sono precisate e affinate, portando alla manifestazione del 30 maggio, che aveva una piattaforma sacrosanta, ancorché, significativamente, molto scarna. Tuttavia, presto, ognuno tornerà alle proprie occupazioni, alla propria competizione, alla propria sfida. Alla propria complessa lotta per la sopravvivenza, materiale e spirituale. Nulla è cambiato, l’orrore è solo un po’ più evidente, anche se, per il momento, non sufficiente a incendiare le città come in altri, imprevisti, angoli del mondo. Ci tocca ricominciare, lasciarci alle spalle tutto questo con una potente sensazione di insoddisfazione, di aver mancato un appuntamento, di aver perso un treno.
Che cosa resta? Per quanto mi riguarda la consapevolezza che entrare in scena dovrà essere, da qui in poi più che mai, una lotta. Se, come abbiamo detto, il teatro che vorremmo non può darsi in questa circostanza, ci sarà comunque il teatro. Distanziato, desolato, resistente, coriaceo, forse vivo e stranamente affascinante, in qualche momento, come l’erbaccia che vedo dalla mia finestra che è cresciuta, enorme, spaccando il marciapiede e che ancora nessuno è venuto a tagliare, ultimo lunare baluardo della fase 1. Forse, almeno per me, ricomincerà nella più compiuta consapevolezza di questo paradosso: non poter accadere, eppure accadere. In questo contrasto c’è tutta la lezione che mi ha consegnato questo momento tremendo della storia recente: l’impossibilità di entrare in scena in questo momento di totale riflusso e decadenza, sottolineato spietatamente dalle sedie vuote e sparute, dagli attori distanti, dalle mascherine, dal clima finalmente dichiaratamente mesto, dall’impossibilità di godere fino in fondo di uno spettacolo, unito alla inesorabile necessità di farlo, di provarci. Lo spazio che c’è tra queste due impossibilità, l’impossibilità di fare il teatro e l’impossibilità di non farlo, è, oggi, il teatro stesso. Ed è anche l’unica forma di anticapitalismo possibile per chi di teatro si occupa.