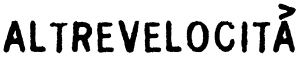Quando, come redazione intermittente di Altre Velocità, parliamo di teatro lo facciamo sempre pensando (e sperando) che la scena sia un “discorso collettivo”, un evento che non si esaurisce nella sua forma spettacolare ma che (al di là degli esiti, più o meno felici dal punto di vista estetico) può dirci, seppure in maniera indiretta, qualcosa rispetto a chi siamo e a chi vogliamo essere – come individui, come comunità e corpo sociale. È anche per questo che, in qualità di associazione, da quindici anni abbiamo deciso di affiancare all’osservazione della scena contemporanea un’attività pedagogica, di educazione allo sguardo negli istituti di primo e secondo grado del territorio emiliano-romagnolo. Siamo convinti, come altri prima di noi e insieme a noi, che di teatro si debba parlare nelle scuole, siamo persuasi che il teatro vada visto, oltre che praticato, perché quello spazio collettivo della visione e della discussione può allenarci confronto interpersonale, può “insegnarci” qualcosa sulla relazione con ciò che è “diverso da noi” (posizioni, idee, persone).
C’è da sempre, questa idea, ripensando alla forma semicircolare dei teatri dell’antica Grecia, di una consuetudine che la città si rispecchiasse nei fatti rappresentati e che vi fosse un’ampia partecipazione anche a livello di censo. Le azioni dei protagonisti spesso sfidavano l’ordine divino e le leggi degli uomini ed erano giudicate dai cittadini attraverso dei veri processi. Ci pare che anche in questa origine ci sia l’idea del teatro come spazio “intermedio” fra lo scorrere della vita quotidiana e la pura “alterità” dell’immaginazione e dell’invenzione, teatro come intercapedine da abitare che contiene elementi dell’uno e dell’altro polo, interstizio da interrogare e particolarmente importante nei momenti di autoriflessione dei singoli e delle collettività. Similmente, per noi, andare in classe significa porsi in una posizione, rivendicata, di “mediazione”: fra l’autonomia dell’arte e la sua possibile funzione sociale, fra le esigenze delle strutture teatrali e gli schemi didattici, fra il corpo dei e delle docenti e il multiforme ambiente di studenti e studentesse cui, attraverso progetti di varia natura, si avvicinano le sensibilità di drammaturghi, attori e attrici e compagnie.
Negli anni abbiamo provato a tenere aperto questo spazio nonostante diverse condizioni obiettivamente avverse: istituzioni scolastiche sempre meno propense ad aprirsi ad accogliere interventi da parte degli istituti culturali della città, travolti dal desiderio di “non perdere tempo”; la scarsa propensione delle istituzioni teatrali a favorire progetti in cui si sollecita un’emancipazione degli spettatori, obbligate come sono nei binari più rendicontabili della promozione; ma, più in generale, il graduale venir meno, nella società tutta, di occasioni in cui il conflitto, il dissenso, il confronto aspro fra diversità siano considerate componenti ineludibili di processi di educazione ed emancipazione. Una direzione – ci sentiamo in dovere di esprimerlo – che si è ulteriormente inasprita con la recente approvazione del DDL Sicurezza (il quale, fra le altre cose, impone ai dirigenti scolastici di sporgere denuncia verso persone specifiche in caso di occupazione di un edificio scolastico e non più verso ignoti, come accadeva in precedenza).
Forse è questo il fenomeno d’insieme in cui collocare anche i recenti casi di manifesta o “velata” repressione del conflitto studentesco avvenuti a Bologna: generalizzando un po’ troppo, viene da pensare che si stia educando non a rispettare le posizioni degli altri, anche quando in contrasto con le nostre, ad ascoltarle, a soppesarle, a metterle in uno spazio mediano che si potrebbe contemplare “insieme”; al contrario si “insegna” quali conseguenze comporta generare momenti di conflitto temporaneo… Cosa accade se anche la scuola, che come il teatro potrebbe offrirsi come intercapedine di confronto fra diversità, si adegua e rischia addirittura di favorire questo restringimento?
Restiamo convinti che la scuola e il teatro possano, debbano continuare ad assomigliarsi, favorendo momenti di discussione ed elaborazione pubblici, spazi in forma di cerchio in cui accendere confronti e scontri. Dobbiamo probabilmente tornare tutti a rischiare di più, dobbiamo tornare a prenderci a cuore le questioni dell’educazione come fatti compiutamente politici, per esempio chiedendo che i conflitti delle scuole, le iniziative dei dirigenti scolastici e dei consigli di istituto tornino in parte a essere pubblici, attraverso assemblee cittadine che è forse giunto il momento di riconvocare, non lasciando da soli insegnanti e personale scolastico; allo stesso tempo ci sentiamo di domandare un maggiore coinvolgimento pubblico a chi è in campo tutti i giorni nelle scuole: serve probabilmente percepirsi ancora di più come parte di una comunità educante, componenti centrali di un ecosistema che può generare o talvolta pretendere alleanze con chi insegnante non è ma ne potrebbe sostenere il lavoro.
A forza di restringersi, quello spazio mediano inscritto nell’origine del teatro, finirà altrimenti per chiudersi, e sarà un problema senza possibilità di ritorno per il teatro, per la scuola, per tutti.
(Altre Velocità)
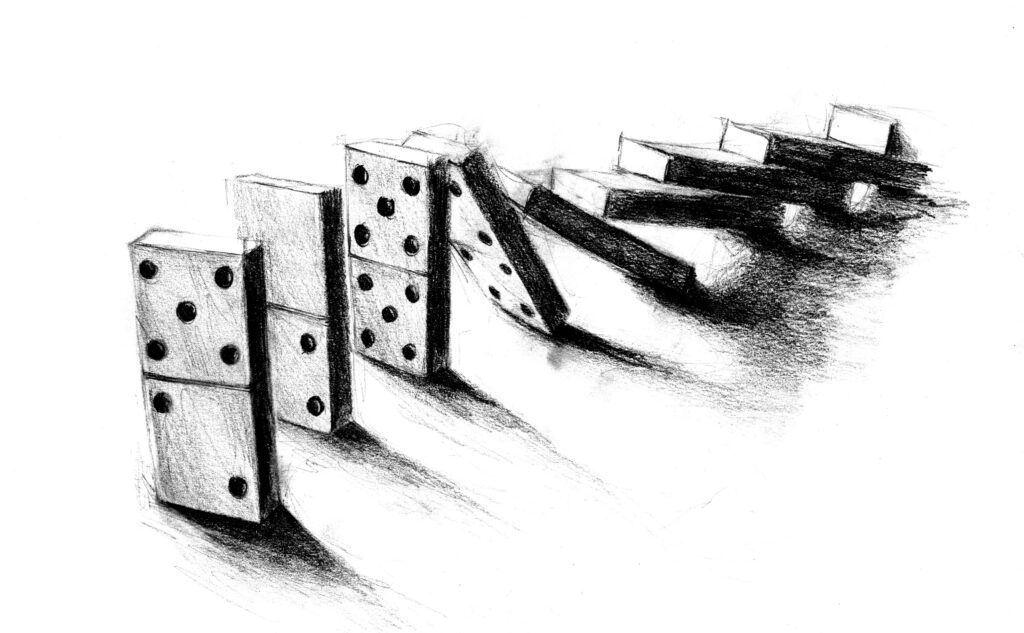
Un possibile filo rosso
di Agnese Doria
Ho seguito le vicende del Liceo Minghetti interessata, a tratti preoccupata, partecipe come qualsiasi cittadina, coinvolta come madre di un alunno della scuola. Teatro e scuola sono parole sorelle: lo diciamo da tempo, da tempo come Altre Velocità proviamo a intrecciare i loro destini, facendo risuonare le domande che entrambe ci pongono. I fatti che sono accaduti non hanno necessità di essere ripercorsi, ci sono arrivati leggendo i quotidiani. Nelle maglie dei fatti ci sono state consegnate delle domande a cui siamo chiamati a rispondere e, magari, a prendere posizione come cittadini e cittadine, esattamente come accade a teatro, per altro.
I tempi concitati e le modalità comunicative hanno inizialmente inasprito le posizioni quando probabilmente quello di cui avrebbe avuto necessità questa comunità era solamente una sosta, prendersi un tempo per digerire, masticare, elaborare collettivamente, ascoltarsi, esprimersi senza giudizio. Quel tempo a cui ci abitua il teatro: un tempo dilatato dove “non è possibile fare nient’altro” se non guardarsi occhi negli occhi in un rispecchiamento.
L’occupazione del Liceo Minghetti ha avuto il pregio di porci di fronte in maniera inequivocabile e sfacciata alla ricostruzione di un modello nel quale il dissenso e la critica non sono ben accetti nei contesti istituzionali nei quali si frequenta un percorso di studi per acquisire forme di sapere “spendibili”, nel quale la libertà di espressione è contingentata a tempi e spazi definiti e definibili. Il polverone mediatico che ha sollevato “il Mingo” ha portato sotto le luci della ribalta le possibili assonanze alla linea di un governo e di un Ministro che agli slanci progettuali e alle prospettive culturali predilige i tecnicismi, che sostituisce punti di riferimento ideali e Maestri/e con burocrazie da adempiere in un generale clima di repressione delle voci controcorrente.
Il teatro qualcosa a riguardo ce l’aveva già provata a dire. Un possibile filo rosso nella stagione ancora in corso è stata la presenza di discorsi capaci di portare il pubblico a ragionare collettivamente attorno a quali siano le libertà inalienabili dell’essere umano (A place of safety di Kepler-452), a quali siano le nuove sfumature e i nuovi modelli (o vecchi?) verso cui stiamo andando e che di fatto limiterebbero le possibilità di espressione, di presa di parola e di critica: pensiamo a Il fuoco era la cura di Sotterraneo. La drammaturgia tagliente di Massini in Matteotti. Anatomia di un fascismo invece ci racconta la storia di Tempesta (così veniva chiamato Matteotti) e delle sue parole: “Il pericolo più grande, la malattia che fa morire un uomo è quella che non senti crescere”. Uno spettacolo capace di interrogarci attorno alle forme di gestione del potere e che ci ricorda quanto sia importante considerare indispensabile, oggi più che mai, occuparsi della cosa pubblica, del bene pubblico, guidati da un pensiero costruttivo, legalitario, partecipativo, paritario, realistico, competente, attraverso atti e parole chiare, come quelle di Giacomo Matteotti e di sua moglie Velia.
E ancora, i racconti di Marta Cuscunà in Freedom. La Resistenza a fumetti: un’autobiografia collettiva di giovani accomunati dall’aver condiviso un tempo e un Paese, che a un certo punto sentirono l’esigenza di cambiare. Ma magari ci trovassimo anche oggi di fronte a un punto di rottura e di cambiamento! Magari i più giovani sentissero l’esigenza di cambiare lo status quo a favore di qualcosa che vogliano immaginare… I colpi inferti a suon di risate da Borghesi e Fettarappa nel loro Spettacolo italiano sono duri da digerire. In un passaggio dello spettacolo ci viene raccontato di come un Sottosegretario del Ministero della Cultura abbia affiancato la creazione dello spettacolo fin dalla prima prova incitando i registi a “guardare dentro di loro (per fare uno spettacolo sulla destra che abita in noi, nda) e ad ascoltare la voce della maggioranza” in un crescendo comico/distopico che arriva a immaginare una fiction dedicata ai “Prof in trincea, capaci di riportare l’ordine nelle scuole invase dagli immigrati”.
Concludendo, pare che il teatro ci abbia avvisato, a suo modo, di alzare la guardia, di non addormentarci e rimanere vigili come una sentinella nel buio «e io, come lei, – scrive Chiara Guidi – vorrei indagare l’orizzonte e saper spostare lo sguardo non per restare inchiodata a un’unica direzione. La sentinella, quando fissa un punto, immagina la possibile complessità delle situazioni. Guardinga, nel silenzio della notte, precisa l’incerto e, mentre guarda, si lascia guardare dalle cose».
Credo che l’identità democratica di una città, di un paese e di un Liceo, non vada solamente rivendicata ma agita giorno dopo giorno, come moltissimi docenti sanno fare e fanno quotidianamente. L’invito a tutti noi che attraversiamo comunità, luoghi, processi, percorsi è quello di farci sentinelle: non granitiche statue che guardano un unico orizzonte difendendo un confine ma esseri viventi capaci di farci guardare dalle cose, provando così a rispondere alla domanda che Kepler-452 ci consegna: e adesso di questa narrazione cosa ce ne facciamo?
L'autore
-
Redazione intermittente sulle arti sceniche contemporanee.